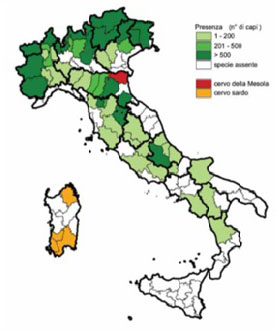La sacra ape
L’ape europea (Apis mellifera Linnaeus, 1758) è la specie di Apis più diffusa al mondo, ma purtroppo anche una delle più minacciate dalle contaminazioni ambientali di origine antropica. Questo singolare insetto, utile bioindicatore, fondamentale per l’equilibrio dei nostri ecosistemi, è stato osservato e analizzato in diversi settori delle discipline naturalistiche, sin dai tempi in cui scienze naturali, fisica, chimica e letteratura non erano rigidamente separate nell’universo culturale dell’uomo occidentale.
Una delle più significative pubblicazioni nell’àmbito delle discipline naturalistiche e letterarie dell’Accademia dei Lincei fu l’Apiarium di Federico Cesi, stampato da Giacomo Mascardi nel 1625, e definito da Giuseppe Gabrieli “la prima monografia entomologica che sia stata composta dopo l’invenzione o modificazione galileiana del microscopio“. Poco prima della pubblicazione dell’Apiarium, Cesi ordinò la stampa e la diffusione della Melissographia, una preziosa tavola di Francesco Stelluti – suo amico e collaboratore alla redazione dell’Apiarium -, omaggio all’emblema araldico di Papa Urbano VIII Barberini, rievocato in questa incisione ad opera di Matthäus Greuter. La tavola riportava una sintesi delle osservazioni scientifiche con il microscopio e rappresentava un trigono di api arricchito dai disegni raffiguranti una serie di particolari anatomici.

Apiarium (particolare, Biblioteca Lancisiana, Roma)

Melissographia (Biblioteca Apostolica Vaticana, Città del Vaticano)
Tuttavia, l’indagine microscopica, e quindi naturalistica, non è l’unico àmbito nel quale sia possibile studiare questo insetto, che, sin dall’antichità, si è arricchito di così tanti significati nascosti, che neanche le più moderne strumentazioni scientifiche potrebbero svelare.
L’ape, il miele, la cera: significati alchemici, esoterici, sacri.
Laboriosa, infaticabile, caratterizzata da numerosi aspetti che la rendono unica, l’ape ha assunto una valenza simbolica importante in molte culture. Questo insetto è legato anche alla simbologia della cera, del miele e dell’alveare, inteso come struttura sociale gerarchica.
Il simbolo dell’ape è presente nei culti della Grande Madre, perché le api costituiscono una società di tipo matriarcale; ad esempio, sono spesso rappresentate insieme alla figura mitologica di Diana Efesina, la Dea dalle molteplici mammelle, simbolo di fertilità, una forma di culto specifica di Efeso.

Artemide di Efeso, particolare (MAN Napoli, Inv. 6278)
Nei Misteri Eleusini le sacerdotesse di Cibele venivano soprannominate “Api” o Melisse (dal nome greco dell’ape, μέλισσα, che significa “produttrice di miele”). Una melissa nutrì Zeus bambino con il dolce miele, che aveva un potere taumaturgico, insieme alla sorella Amaltea, che invece lo alimentò con latte di capra.
Anche la Pizia, sacerdotessa di Delfi cara ad Apollo, veniva chiamata Melissa, ovvero l’Ape, e lo scrittore Pausania, nelle sue Periegesi della Grecia, narrava un vecchio mito secondo il quale uno dei cinque templi dedicati ad Apollo in Delfi era stato edificato dalle laboriose api con la cera. Esisteva uno stretto legame tra l’ape, simbolo femminile, e il culto solare di Apollo, di valenza maschile.
C’è poi un nesso tra le ninfe e le api: la danza. Le api comunicano tra di loro con armoniosi schemi ben definiti, per ritrovare una fonte di cibo, con grande precisione per quanto riguarda direzione e orientamento rispetto al sole. Questo metodo danzante di comunicazione, associato alla forma circolare, al sole e al suo orientamento nello spazio, hanno creato una serie di connessioni simboliche che si ritrovano nei riti: il ritrovamento del labirinto, con i meandri che richiamavano il movimento delle api, nello spazio sacro, la danza come azione sacra che talvolta induceva estasi o possessione.
L’ape compare anche nella simbologia dei Rosacroce, nella famosa incisione dal Summum Bonum di Robert Fludd (1629), che ritrae una croce sormontata da una rosa con la scritta in latino «Dat Rosa Mel Apibus», motto dei Rosacroce. Il significato è «la rosa dà il miele alle api».

Robert Fludd, frontespizio del Summum bonum, 1629.
Il miele, per molto tempo unica fonte di zuccheri a buon mercato, fu la ragione per cui l’ape iniziò a essere anche presa come simbolo dell’abbondanza e della ricchezza. Dal miele, per numerosi miti greci, celti e germanici, si produceva l’ambrosia, bevanda degli Dei, dal momento che solo gli immortali potevano gustarla. Per la loro delicatezza nel percepire i suoni, gli Elleni ritenevano che le api fossero ambasciatrici delle Muse.
Il miele, estremamente raro e prezioso, era legato al mondo infero: veniva usato nelle offerte sacrificali dei riti funebri e destinato al sacrificio per le divinità ctonie. Glauco, figlio di Minosse e Pasifae, rinasce dopo essere affogato nel miele. In Egitto e a Roma esisteva la pratica di imbalsamare i morti con il miele, per le sue proprietà anaerobiche e antibatteriche. Secondo Stazio, anche il corpo di Alessandro Magno fu immerso nel miele ibleo, e così Augusto, tre secoli dopo, riuscì e intuirne i tratti del volto.
Il miele era certamente legato anche alla vita e alla nascita: era l’unico alimento destinato ai neonati nei primi due giorni di vita, ed era il nutrimento per i figli “divini” Zeus e Dioniso. Pitagora attribuiva la sua longevità a una dieta di miele.
In alchimia, invece, l’alveare è uno dei simboli alla materia prima che si trova dappertutto e, mediante il processo di trasmutazione, può essere trasformata nella Pietra Filosofale. L’associazione simbolica avviene attraverso la “cabala fonetica”, o “lingua degli uccelli”, usata dagli iniziati per nascondere messaggi segreti mediante ricercate assonanze linguistiche, soprattutto nella lingua originale, il francese. Il nome francese dell’alveare, la ruche, richiama proprio da vicino il termine roche, roccia, ossia la pietra.
Tra le varie caratteristiche, alle api fu attribuita anche la purezza, come scrive Virgilio nel IV libro delle Georgiche: «non si abbandonano all’amore, non si infiacchiscono nei piaceri e non conoscono né l’unione dei sessi né i dolorosi sforzi del parto».
Mitologia greca ed egizia
Secondo il mito, furono le api a fabbricare il secondo tempio di Delfi e, in Grecia, esse furono emblema di lavoro e di obbedienza. Furono anche associate all’idea di monarchia come organizzazione ideale della società e dello Stato.
Per la loro abitudine di nascondersi durante i mesi invernali e di rimanifestarsi in primavera, le api sono simbolo della rigenerazione, del ciclo della vita costituito dall’alternanza di morte e rinascita. Per i Greci, questo ciclo è descritto nel mito della dea Demetra, che per sei mesi si rallegrava della presenza di sua figlia Persefone, mentre per altri sei mesi, nell’arco dei quali la figlia tornava a vivere insieme ad Ade nell’oltretomba, lasciava la terra senza i suoi frutti, nella stagione buia e fredda.
Le api avevano una funzione sacra e iniziatica: le si trova raffigurate sulle tombe come segno di rinascita dopo la morte. L’ape è quindi simbolo della nascita a nuova vita, ma anche simbolo solare di saggezza, virtù, operosità, luce, anima collegata al divino. Nella tradizione ellenica l’ape rappresenta l’anima discesa fra le ombre che si prepara al ritorno, proprio perché nella stagione invernale sembra sparire nascondendosi nell’alveare. Talvolta essa s’identifica con Demetra.
In Egitto l’apicoltura esisteva già intorno al 2600 a.e.v. L’ape era il simbolo della regalità del Basso Egitto. Nell’arte e nelle tradizioni dell’Egitto essa è simbolo dell’anima ed è di origine solare, essendo nata dalle lacrime di Ra, il Dio-sole, cadute sulla terra. Anche per i cristiani, le api avrebbero avuto origine dalle lacrime di Cristo, secondo alcune leggende. In Egitto, scene di apicoltura sono visibili sui bassorilievi della tomba di Niuserra, re della V dinastia, e la raccolta del miele viene descritta sulle pareti della tomba di Rekhmire, gran visir di Amenhotep II, faraone della XVIII dinastia. Il re dell’Alto e del Basso Egitto era chiamato “principe ape” perché l’ape, simbolo solare, raffigurava il principio della regalità. Nel tempio il gran sacerdote accendeva una candela di cera d’api per dare luce al volto invisibile della divinità. Anche i sacerdoti erano definiti “api” (proprio come le sacerdotesse di Cibele o come la Pizia), come manifestazioni terrene del Dio Ra.
L’ape nei miti e nella letteratura classica
Secondo Platone, le anime degli uomini sobri si reincarnano sotto forma di api.
Porfirio, filosofo del III secolo e.v., narra che gli antichi chiamavano ‘mélisse’ le anime, ma solo quelle destinate alla rinascita e a vivere secondo giustizia, e poi tornare là da dove provenivano dopo aver compiuto la volontà degli Dei: “l’anima dapprima discende nel mondo sensibile, nei corpi, e dopo si pone il problema del ritorno all’origine attraverso la vita morale”. [Porfirio, Antr. 34, 5 ss]
Anche il poeta Virgilio, nel IV libro delle Georgiche, prende le api come esempio di operosità e vede il lavoro non più come una condanna, ma come dono divino, rivalutandolo dal punto di vista etico. La figura delle api assume particolare importanza poiché l’Autore mostra le api richiamando la metafora di Cicerone: «Come gli sciami delle api si riuniscono non già per costruire i favi, ma costruiscono questi in grazia del loro istinto associativo, cosí gli uomini si dedicano con solerzia all’azione e alla speculazione in quanto naturalmente congregati in società, ancor piú delle api stesse. Pertanto ove quella virtú, che risulta dall’obbligo di proteggere gli uomini, cioè dalla sociabilità umana, non si unisca alla conoscenza teorica, quest’ultima sembra andar errando sterile e in solitudine. Parimenti la magnanimità senza il sentimento sociale e l’unione degli uomini non sarebbe che una sorta di inumana ferocia. Pertanto l’esigenza sociale e la comunione degli uomini ha la precedenza sull’interesse teorico.» (Cicerone, Opere politiche e filosofiche).
Le api hanno un’organizzazione comunitaria – descritta anche da Plinio nell’XI libro della Naturalis Historia – che si differenzia dalla struttura sociale di altri animali per la fedeltà alla casa e alle leggi, per la condivisione del cibo e per lo spirito di abnegazione, in una visione stoica della comunità. Le api si sacrificano per il bene comune e mantengono una dedizione totale verso il capo.
Rege incolumi mens omnibus una est;
amisso rupere fidem. Virgilio, Georgiche IV, 212-213
(Finché il re è sano e salvo, tutte [le api] la pensano in egual maniera, ma, perduto il re, il patto è infranto.)
Con le Georgiche, Virgilio si allontana dalla pace consolatoria della natura descritta nelle Bucoliche per trasformare il paesaggio in cultura e conoscenza, sorretta dal lavoro dell’uomo.
“Il lavoro è tenue, ma darà non tenue gloria.” (IV, 6)
Per questi motivi, Virgilio arriva alla conclusione che le api abbiano una origine sacra e che conservino quella luce divina nella parte più profonda del loro essere. Esse sono, quindi, simbolo dell’immortalità dello spirito che dà forma a tutti gli esseri viventi che abitano la Terra.

Illustrazione delle Georgiche di Virgilio (Wenceslas Hollar, 1654 – da wikipedia).
A questi indizii, e prodigiosi esempi
riflettendo talun pensò, che l’api
abbian celeste origine, ed un raggio
chiudano in sen de la divina mente:
poiché diffuso per le terre e i mari,
e pei campi del ciel vuolsi che immenso
spirito il mondo informi, e da lui vita
traggan uomini, armenti, augelli e fiere;
e in lui di nuovo poi da i corpi sciolte,
non soggette a perir, tornino l’alme
a rïunirsi, e redivive il volo
spieghino al cielo ad abitar le stelle. Virgilio, Georgiche IV, 338-349
Le api, dunque, ci insegnano che la fedeltà alla casa e alle leggi, la condivisione del cibo e lo spirito di abnegazione nello svolgimento del proprio lavoro, uniti a un profondo senso di appartenenza a una comunità, sono virtù divine ed elementi fondativi di un paesaggio umano, di una struttura sociale, di uno Stato.
Bibliografia
- Hans Biedermann, Enciclopedia dei simboli, Garzanti Editore, Milano, 1991.
- Federico Cesi, Apiarium, Roma, Ex Typographeio Iacobi Mascardi, 1625.
- Cicerone, Opere politiche e filosofiche, UTET, Torino, 1953, vol. I, pp. 357-358, 410.
- Publio Virgilio Marone, Georgiche, Sansoni Editore, Gruppo Editoriale Fabbri, Bompiani, Sonzogno, 1993.
- Porfirio, L’antro delle Ninfe, Milano, Gli Adelphi, 1986, 34, 5 ss.
- Francesco Stelluti, Melissografia, Roma, 1625.
Immagini
- in testata: Disco d’oro con api, (700-600 a.e.v., collezione del Nasher Museum of Art).
- in evidenza: Favo con api, Galleria di Napoli (frontone ingresso via S. Brigida).





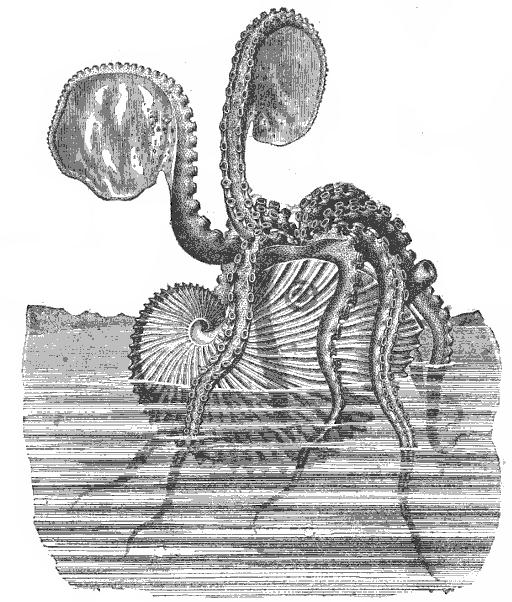
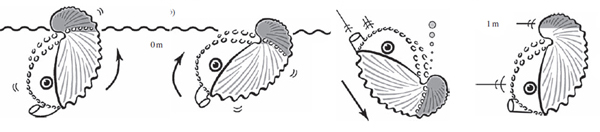
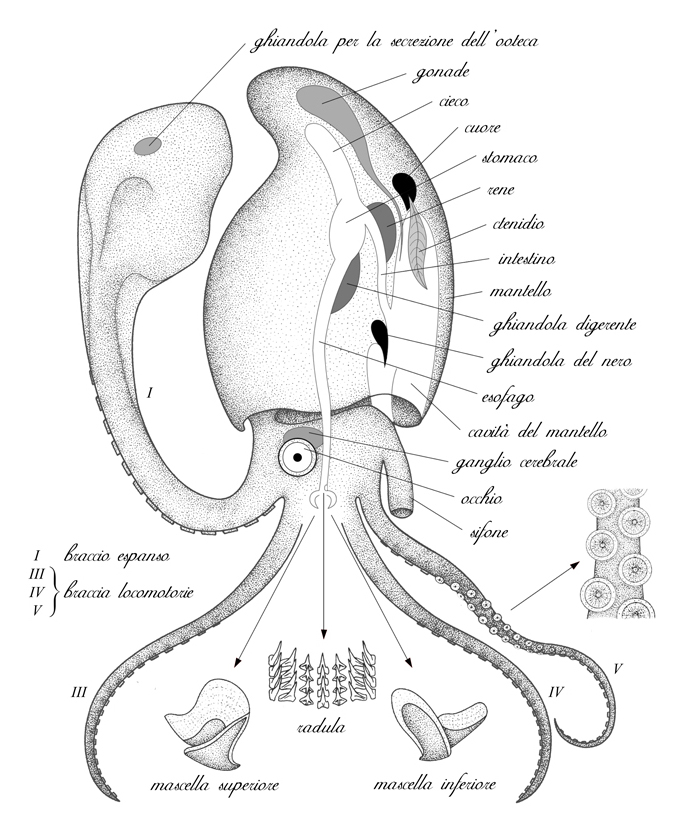
![Caccia al cervo con l'arco (Jan van der Straet, Venationes ferarum, avium, piscium, pugnae bestiariorum et mutuae bestiarum [...], Anversa, Philippe Galle, 1602).](https://www.asciacatascia.it/main/wp-content/uploads/2017/11/36-caccia-al-cervo-05.jpg)

![Caccia al cervo con armi da fuoco (Jan van der Straet, Venationes ferarum, avium, piscium, pugnae bestiariorum et mutuae bestiarum [...], Anversa, Philippe Galle, 1602).](https://www.asciacatascia.it/main/wp-content/uploads/2017/11/32-caccia-al-cervo-01.jpg)